[di Ilaria Tagliaferri]

Neil Klugman vive con una zia strampalata, ed è un bibliotecario. È il protagonista, poco più che ventenne, del racconto di Philip Roth, Goodbye Columbus, pubblicato nel 1959. Neil Klugman si innamora di Brenda Patimkin, ricca figlia di un imprenditore che produce acquai e lavandini, che abita nei quartieri chic e si è rifatta il naso. Succede tutto durante un’estate. Lui le rivolge spesso feroci battute per rimarcare la loro differenza sociale, lei lo invita a trascorrere giorni di vacanza a casa sua, con i suoi genitori e i due fratelli, che non fanno altro che mangiare piatti sostanziosi mentre parlano di sciocchezze, e in un seminterrato custodiscono un consolante frigo proibito, pieno fino all’orlo di frutta deliziosa.
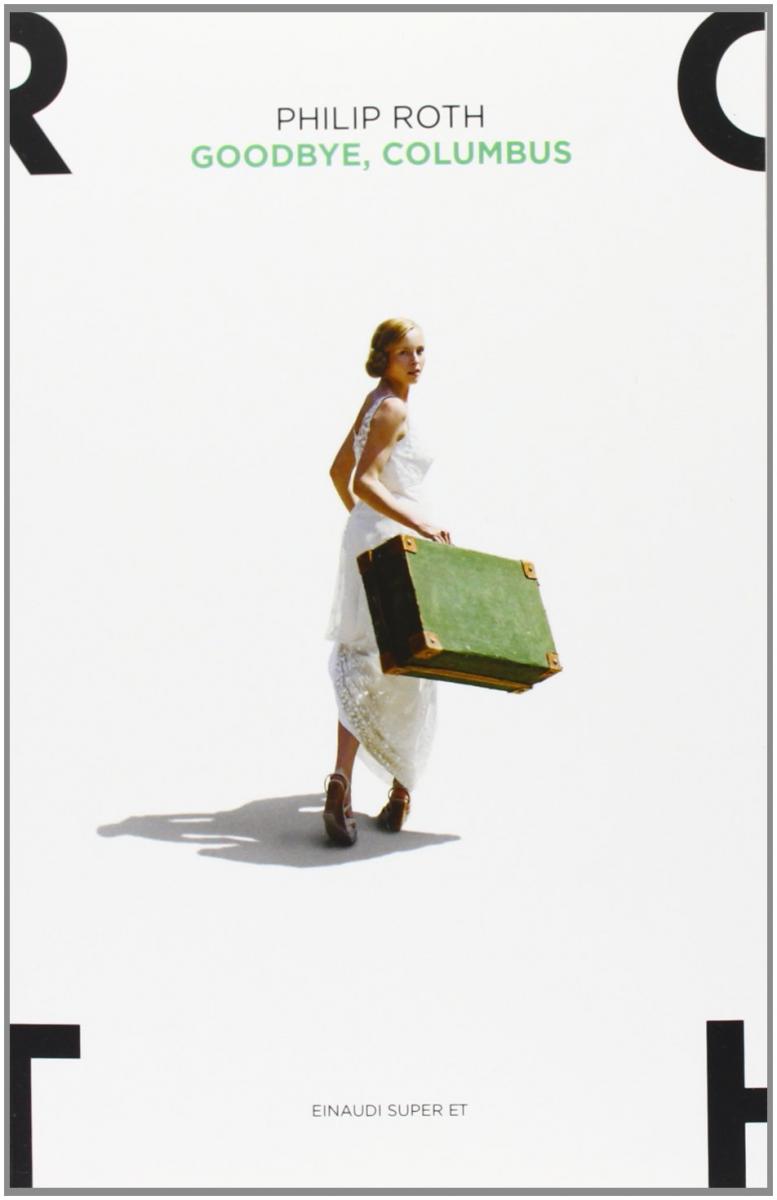
È uno scritto di Roth, e tutte le volte che leggo questo autore mi viene in mente quello che scrive di lui Jeffrey Eugenides: «Sin dall’inizio la voce di Roth è sempre stata così fluida e complice che aveva l' effetto di afferrarti per la collottola». È così: Roth ci fa stare nella storia con umorismo, amarezza, profondità, e con l’attenzione instancabile, la dedizione che la sua scrittura richiede. Quando è comparso, nel racconto, il mestiere di Neil, quasi stentavo a crederci: la biblioteca è arrivata tra le righe con il passo lieve, quasi mesto, e allo stesso tempo potente con cui spesso la si incontra nelle narrazioni. E lui, il bibliotecario, è comparso al cospetto del lettore direttamente alle prese con il suo mestiere, in un misto di torpore, rassegnazione e amore vissuto di soppiatto. Neil fa il bibliotecario non per passione, ma perché gli è capitato, anche se sa che non sarà il lavoro della sua vita. Trascorre le ore guardandosi intorno, sistemando i cartellini dei libri, e confessa che sta aspettando il momento in cui sotto la sua pelle scoprirà «un sottile cuscinetto d’aria che separa il sangue dalla carne. Qualcuno ve l’aveva pompata mentre davo un libro , e così la vita d’ora in poi non sarebbe più stata né un buttar via, come per zia Gladys, né un accumulare, come per Brenda, ma un procedere di rimbalzo nel torpore». Neil sembra imbalsamato nelle sue giornate di lavoro, ripete sempre gli stessi gesti, ha intorno colleghi strani, si annoia, guarda le studentesse salire la maestosa scalinata principale ma pure i suoi pensieri lussuriosi sono fiacchi.

Un giorno però, all’entrata della biblioteca, di fronte alle statue di pallidi leoni che la custodiscono, Neil nota un ragazzino nero che con i leoni ci sta parlando, a suon di ringhiate e brevi minacce. Più tardi il ragazzino gli chiederà dove sia la sezione «del cuore» con «il più forte accento dialettale dei negri del sud». Ed è esattamente a questo punto, di fronte a una richiesta stramba, difficile da interpretare, che Neil si sveglia dal torpore. Non capisce subito, ma quasi: il ragazzino pronuncia art come se fosse heart, e Neil lo spedisce nella sala Tre, dove ci sono i libri con le riproduzioni dei dipinti degli artisti famosi. E lì lo ritrova, dopo alcune ore, con un libro di Gauguin aperto sulle ginocchia. Lo scambio di battute tra Neil e il ragazzino ha quella dolcezza burbera, essenziale, quasi scioccante, che secondo me è una delle (tante) cose della scrittura di Roth che ci tiene, appunto, avvinghiati alle sue pagine per la collottola, e mi ha fatto pensare a quanto la figura del bibliotecario – anche del più sornione, indolente e annoiato – si accenda inevitabilmente laddove il libro incontra l’umano. In questo caso poi, c’è un incontro con l’infanzia, quella smarrita, curiosa e senza filtri, che vagabonda in un luogo nuovo e che non ha paura di chiedere, di cercare, di fermarsi a lungo a fantasticare sulle figure. Neil il bibliotecario sfiorerà guai grossi per difendere il diritto di questo ragazzino con i capelli come «minuscoli cavatappi» ad ammirare, per ore, il prezioso libro di Gauguin.

Ho ripensato a quante volte, in tanti anni trascorsi dietro al bancone o in giro per la sala, mi è capitato di infrangere qualche regola per far sì che alcuni momenti “perfetti” di incontro con i libri restassero tali: sono incontri mai scontati, mai banali, a volte si manifestano in forme che hanno poca grazia, poca gentilezza, in un misto di impulsività, soggezione, confidenza. Ho visto, in questi anni, bambini, ragazzi e adulti spostare letteralmente i tavoli della biblioteca – gli scaffali sono resi troppo pesanti dalla presenza dei libri – per sistemarsi in maniera più comoda a leggere o a studiare: gli ultimi che ho rimbrottato sono stati un ragazzo e una ragazza, credo una giovane coppia, che aveva trascinato il tavolo rotondo della consultazione fin sotto la finestra che dà sul parco. Si sono stupiti quando ho detto loro che la cosa non si poteva fare, e credo onestamente di averglielo detto con un mezzo sorriso di comprensione.
Mi diverte, mi meraviglia sempre e a volte mi commuove vedere le sale della biblioteca che si animano di strani personaggi. Personaggi, sì, non amo troppo chiamarli utenti, mi sa di freddo, di impersonale. Una volta messo piede in sala, soprattutto se lasciati soli a bighellonare in mezzo agli scaffali, mi piace pensare che questi lettori entrino dentro a una dimensione, mentale e intellettuale ma anche fisica e spaziale, che è essa stessa una storia da raccontare: per certi versi è una dimensione sospesa, forse solo immaginata, ma comunque è staccata dalla realtà che hanno lasciato alle loro spalle nel momento stesso in cui hanno varcato la soglia delle sale con i libri. La cosa più interessante è che però, di quella realtà, i lettori si portano addosso i segni, nei dettagli, nel loro modo di muoversi, di parlare: e nel silenzio, nella quiete delle sale questi segni si colorano, è come se si gonfiassero, sono più evidenti, sono l’incipit di una miriade di storie. E spesso, queste storie iniziano proprio con una domanda, come quella che il ragazzino fa a Neil Klungman. I lettori, in biblioteca, possono chiedere di tutto, e in tutti i modi: il bibliotecario non ha certo la risposta a ogni interrogativo e non ha letto tutti (ma proprio tutti!) i libri presenti in sala – quest’ultima cosa pensavo, prima o poi, di scriverla su una maglietta, o su un cartello da donna-sandwich, ma poi ho pensato come faccio conciata così a muovermi tra gli scaffali, che ci sono pure quelli bassi, anzi bassissimi? – ma uno dei suoi compiti più importanti è trovare non tanto le risposte, ma i modi per accogliere le domande.


Capita, quando non riusciamo a rispondere con esattezza alle richieste dei lettori, di deviarle, di piegarle verso la concreta possibilità di farli uscire dalle sale con un libro che prenderanno in prestito. Con più di un libro, se siamo fortunati, se il vecchio discorso che faccio sempre agli studenti in crisi con le ricerche e le tesine – prendete più libri, usate più di una fonte, mettetele insieme, integratele una con l’altra – per una volta, ha successo. Non sempre riusciamo a cercare i testi con la tempestività, la calma, la creatività necessarie per soddisfare il lettore, ma a volte l’attenzione che mettiamo in questi primissimi momenti dell’incontro, nel rispondere alla sua domanda, per bislacca o strampalata che sia, sono fondamentali. Semplicemente, ci consentono di rivederlo. Quando un lettore ritorna e ti cerca per raccontarti se il libro che gli avevi consigliato gli è piaciuto, o ti cerca proprio per farsene consigliare altri, è una vittoria. Frastornante, rumorosa. Così tanto che a volte scuote la quiete: capita che con i lettori e le lettrici più appassionati si alzi un po’ la voce, in sala, di fronte agli scaffali, mentre scegliamo i libri. Perché ai libri sono legate le esistenze delle persone, i figli gli acciacchi le insonnie le gioie, e tutto questo, anche piccoli brandelli di tutto questo, è inevitabile che venga fuori fra un titolo e l’altro. A quel punto, gli altri lettori alzano il naso dalle loro pagine, e ci fanno sssshhhh. Così sfatiamo un altro mito, perché non è affatto vero che sia solo la bibliotecaria a stare perennemente con il dito sulle labbra per zittire a destra e a manca, anzi. È una di quelle tante deroghe di cui sopra, e spesso penso che sono talmente tante, le regole infrante a fin di letture, che dovrei davvero decidermi a raccoglierle e a provare a scriverle, queste storie. Nel frattempo leggete Goodbye Columbus, e ditemi se davvero Neil Klungman, pur così sarcastico e sfaticato, alle prese con il ragazzino e con l’arte, non vi sembra proprio il bibliotecario che vorreste incontrare mentre vi aggirate tra gli scaffali.
Le fotografie di questo post sono state scattate alla Biblioteca Tiziano Terzani di Villa Montalvo (Campi Bisenzio, Firenze).

