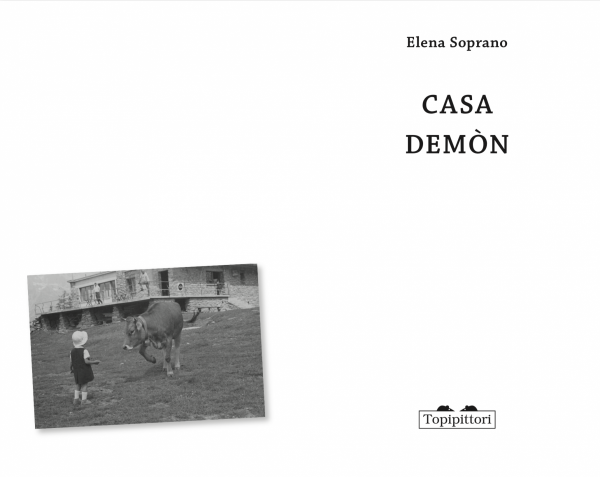Nuovo martedì di festeggiamento dei 10 anni della collana Gli anni in tasca, uscita nel 2009. Oggi pubblichiamo il primo capitolo di Casa Demòn di Elena Soprano, strepitoso racconto di un'infanzia selvatica, incantata, difficile, fra quegli universi metalogici e diversi come il giorno e la notte che sono una mamma e un papà. Buona lettura.
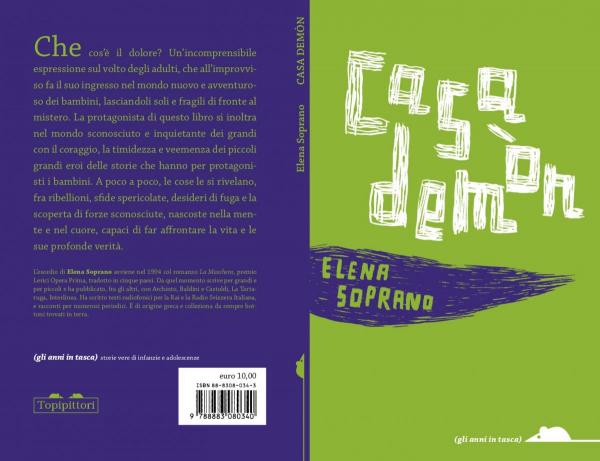
Il primo giorno di scuola, in prima elementare, disegnai una casetta blu con gli occhi gialli. Era una piccola casa che sembrava fatta di capelli spettinati, di ciuffi ribelli e cattivi come quelli di Crudelia Demòn (nel film era De Mon, ma per me è sempre stata Demoòn, di suono e di fatto). La Crudelia di un piccolo album illustrato che avevo fin dai primi tempi dell’asilo e che mi terrorizzò per tutta l’infanzia. Guardavo, leggevo la storia girando le pagine fino in fondo. E lei mi aspettava lì, nell’ultima illustrazione, con quegli zigomi a picco sulle guance scavate che facevano slittare il mio sguardo sul suo ghigno diabolico come a dire: «Ma non finisce qui!»
E infatti non era mica finita. Aspettando di addormentarmi, nel buio della camera, a ogni rintocco di campanile immaginavo un passo di Crudelia verso il mio letto. Sotto le coperte, mi rannicchiavo abbracciando gambe e piedi. Mi sentivo, col cuore a tamburo, diventare a forma di cerchio. Speravo di ridurmi a un puntino. Nessuna altra immagine riusciva a neutralizzare l’effetto Demòn. Nessuna Biancaneve, nessuno dei Sette Nani. Era una questione tra me e lei. Era una guerra con qualcosa che era uscito dal libro.
Ho disegnato la casetta in mezzo al nulla, con le finestre gialle che somigliano a occhi spalancati. Non c’è nessun personaggio né un cespuglio né una nuvola. C’è solo un cielo di quadretti e anche piuttosto basso dato che la pagina, per circa metà, è occupata dalla data. È scritta a matita, con lettere enormi, tremolanti, quasi dei tentacoli che vogliono scappare dal foglio. Mi guardo un attimo intorno. Ci sono alcuni che sono stati all’asilo con me. Altri che abitano nella mia via, un paio addirittura nel mio palazzo, come il Mizzi, che non ha fatto la scuola materna e però colora tranquillo, sorridendo. Nessuno di loro ha avuto fretta di finire. E soprattutto nessuno ha scelto un colore così cupo. Del resto, pensandoci dopo, il colore non poteva che essere il blu, il colore della mia paura, lo sfondo notte di quella pagina su cui ghignava la tremenda Demòn.
Il mio disegno mi sembra bruttissimo. Lo copro per un attimo, con un palmo. Rimediare, rimediare subito. Penso che se cancellassi il tutto, potrei ricolorare la casa di rosa o di arancione. E fare qualche fiore intorno. Giusto per abbellire un po’. Si poteva disegnare ciò che si voleva. Perché non ho fatto un bel sole? All’asilo ero una campionessa in soli. E poi il sole può essere solo giallo, al massimo arancione, quando tramonta.
Provo a dar di gomma. Il tetto della casa si schiarisce. Aumento la velocità, se solo riuscissi a schiarirla un altro po’, potrei ripassarla di azzurro. La mano però mi si ferma di colpo e gira la pagina: il foglio è bucato. Sono incredula per la facilità con cui si èrealizzato il danno. Copro il disegno con la mano. Mi sento come quando scappa la pipì e sei a un passo dal non riuscire a trattenerla. Ho le orecchie in fiamme. E qualcosa che mi si sta gonfiando nel petto come un’alta marea. Vedo la maestra avvicinarsi, sorridente. Non cammina, è come se scivolasse sul pavimento. Ha intuito il mio subbuglio. Muove le labbra, dice qualcosa, ma io non sento nulla. “Adesso mi picchia” penso.
L’idea dei maestri picchiatori è di mio fratello Stefano, lo Stefano, che alla vigilia del mio primo giorno di scuola mi mette sul chi va là: «Picchiano.» In realtà nessun maestro gli ha mai messo le mani addosso. Ma i maestri, coi loro cinque in matematica e in italiano, sono i mandanti. È mio padre a elargire con grande generosità i ceffoni, uno per ogni insufficienza.
«Picchiano i somari come te», gli faccio io. Non so perché, ma dentro di me ho la granitica certezza che le femmine a scuola possono essere solo brave.
«Sì, vedrai», mi rifà lui.
Per il momento vedo solo la mia cartella. Me l’ha scelta mamma alla cartolibreria Bonazzi in piazza Campello. Mi ha detto che è di cavallino. È di pelle rossa, con le bretelle e il dorso ricoperto di una pelliccetta a pelo corto, bianca, picchiettata di puntini marroni. E io mi sono immaginata subito un cavallino al galoppo nei pascoli alpini con la mia cartella sulla schiena. Neanche per un istante ho pensato che il cavallino sia la cartella. Sono fatta così, censuro il pensiero prima che il suo messaggio mi possa far male. Come la storia della volpe della vicina, la signora Berta. La nostra vicina di casa ha una grande volpe imbalsamata in salotto. Ha la bocca un po’ aperta che lascia intravedere i denti, una folta coda dalla punta bianca, gli occhi di vetro con un’espressione arrabbiata.
La Berta ci aveva raccontato che la volpe si era “ambalsamata” perché suo fratello “l’aveva presa dentro” con l’auto, di notte. Per me le cose erano andate esattamente così: la volpe in mezzo alla strada, fissa sui fari dell’auto che gli sta venendo di fronte. L’uomo arriva, la investe e dallo spavento la volpe si imbalsama. La sua postura è regale, quella dei momenti migliori. L’occhio però è rima- sto arrabbiato, col vetro che ne acuisce l’espressione che sembra voler dire: «Più piano, accidenti, più piano!»
Per non far rimanere male Simona, la Simo, mia sorella minore, la mamma regala anche a lei una cartella. Ma è arancione, di plastica, con stampati in alto alcuni personaggi Disney tra cui spiccano non Topolino o Paperino, ma la Banda Bassotti. Non ha neanche le tracolle.
«È una cartella da asilo», faccio io. Però, per vedere quanta roba ci sta in una cartella, la riempiamo fino a sformarla. Ci mettiamo gli album da colorare, un paio di orsi, anche la bambola Domenica, che è di stoffa e si può piegare e ripiegare. Le pantofole della Simo che sono più piccole delle mie. Un’armonica, un salvadanaio a forma di cane, le calze della Befana vuote che ogni tanto riemergono dal fondale della nostra cassa dei giochi. Ridiamo un sacco. Però, di riempire la cartella di cavallino non se ne parla, anche se gli orsi ci starebbero più comodi. Deve durare fino alla quinta.
Dopo cena mio padre ci chiama in sala. Dice che il Presidente della Repubblica vuole augurare a tutti gli alunni buon anno scolastico. Si chiama Leone, un nome che mi dà subito grandi speranze. Mi immagino una specie di re della foresta che farà un discorso a tutti gli altri animali. Qualcosa di solenne e unico, solo per noi della prima elementare, ma che i più grandi non vedono l’ora di riascol- tare per ricordare il brivido dell’inizio. Rimango perplessa quando vedo un omettino emergere dalla scrivania con un paio di occhiali piuttosto spessi. Legge qualcosa su un foglio con un tono di voce che mi è subito antipatico. Per un attimo vorrei cambiare segno zodiacale, dato che sono del Leone e per me essere del Leone, come mio padre, ha sempre significato qualcosa di speciale. Non capisco una parola di quello che dice, ma bisogna star lì. Sull’ascoltare poi è un’altra faccenda.
«Quando parla dell’asilo chiamami...» fa la Simo al pa’, e si invola in camera. Dall’alto dei suoi tre anni può dire e fare quello che vuole. Io e lo Stefano abbiamo già perso da un pezzo il potere dell’ultimo nato e ci sorbiamo un discorso le cui parole sfiorano le nostre orecchie per poi riprendere il largo. Non ci sediamo neanche, rimaniamo in piedi sperando che il tutto finisca presto. Risento sotto le mani la pelliccia morbida del cavallino, di un liscio mai sentito prima. Le dita, quando ce le appoggi sopra, scorrono giù prendendo velocità. Ci penso fino a quando il pa’ esclama: «Allora, avete capito?» E rivolgendosi a mio fratello in tono già di rimprovero: «Hai capito?».
Io faccio segno di sì con la testa più volte, gli occhi grandi di finto entusiasmo. Lo Stefano mormora un «Ma sì...», a spalle curve e voce a perdere.
Mi sembra domenica mattina perché il pa’ è a casa. Però non è domenica, altrimenti ci sarebbe odore di torta di mele o di ciambella. La Simo dorme. Lo Stefano, che va già alla medie, è stato il primo a uscire, con la sua cartella di tela color militare, perennemente floscia. I colori delle cose sono più intensi. Gli alberi più verdi, il cielo più azzurro. I mattoncini sul terrazzo della nostra casa co- lor nocciola sembrano diventati di cioccolato. Come se la luce fosse in festa prima del suo viaggio di ritorno, verso l’autunno e l’inverno. Non so se avere paura o no. Fino a ieri non ne avevo. Ma se viene anche il pa’, si vede che la cosa è davvero seria e forse qualche pericolo c’è.
Una mano al pa’ e una alla ma’, camminando come se fossi su un’altalena. La scuola non è lontana. Arriviamo in fondo alla via, attraversiamo una strada fino a che non costeggiamo i giardinetti. Entriamo. Il cortile è già pieno di bambini. I piccoli sono con i genitori, i più grandi da soli. Il pa’ saluta a piena voce e, mollata la mia, stringe la mano a molte persone. Mi sento come quando qualcuno ti vuol far scendere dall’altalena a forza e tu, sul seggiolino, cominci a sbandare di qua e di là spezzando l’equilibrio dell’oscillazione.
Un maestro suona un fischietto. Due volte. È il maestro che in seconda elementare bocciò lo Stefano. Ha terribili orecchie a sventola. E una montatura di occhiali nera con quelle spesse lenti piene di righe che fanno gli occhi minuscoli, lontani, che poi hanno sempre bisogno di arrabbiarsi per essere notati. Alza di scatto un braccio, pochi secondi e i suoi alunni gli si radunano intorno. Sudati. Alcuni sbuffano. Raccolgono di malavoglia le cartelle buttate in terra. È una quinta maschile che stava giocando a palla-guerra. Il maestro non dice una parola. Guarda con gelo la classe fino a che un bambino non gli porta, a testa bassa, la palla. Allora col dito fa il segno di procedere e la fila di bluse nere si avvia, serpeggiando mogia e silenzio- sa in mezzo all’entusiasmo dei piccoli.
Il chiasso scema fino a che non si sentono di nuovo gli uccellini dei giardinetti. In cortile sono rimasti solo gli alunni di prima. Sono scesa da quel senso di altalena già da un pezzo e ho le mani serrate alle bretelle della cartella. Le maestre hanno un elenco, a mano a mano chiamano i bambini e li radunano a sé come pulcini. Ci sono bambini che non ho mai visto. Qualcuno piange. Ri- conosco la Paola del mio palazzo. Ci sorridiamo. Sto per mettermi vicino a lei mentre continua la smistamento, ma viene chiamata dalla sua maestra: la signorina Forni. Speravo di non capitare con questa. È alta, anziana e secca proprio come un grissino che è stato troppo nel forno, e indossa un minaccioso grembiule nero. Nei pomeriggi d’inverno passeggia spesso nella mia via a braccetto della madre e delle sue due sorelle, secche e magre come lei. A braccetto a due a due, a quattro se non passano macchine, per prendere l’ultimo tiepido sole come gigantesche lucertole su due gambe. Tra di loro parlano sempre sottovoce, anche se in strada non c’è nessuno. Forse perché la Forni la voce la deve risparmiare per la scuola. Infatti è famosa per i suoi «Perdinci!» Ne sta lanciando qualcuno anche adesso, mentre arpiona i bambini dal caos per metterli in fila.
Diamine. Nessuno mi ha detto cosa fare. Se aspettare di essere chiamata o andare io da una maestra. Quando non so cosa fare rischio che non faccio niente e poi sbaglio, perché invece bisognava fare qualcosa. Come quella volta a danza che ero prima della fila ma non ricordavo più con che piede iniziare e anziché partire sono stata ferma, stoppando tutti, cosicché mi hanno messa in fondo, dove sono sempre rimasta per tutti gli anni che ho frequentato danza, con la scusa, mi dicevano, del “sei alta”.
Qualcuno mi spinge da dietro e mi ritrovo tra dei bambini che fanno gruppo intorno a una maestra grassa, sorridente, già su di età e senza grembiule. Questa è la sua ultima prima, poi andrà in pensione. È rotonda come una balena, ma si chiama Delfina e ci dice: «Salutate i genitori.»
Io agito la mano al vuoto, sorridendo per far vedere che va tutto bene. Non so dove siano finiti i miei, saranno sicuramente lì da qualche parte, ma non li distinguo più.
Dentro la scuola non ci sono i suoni a rimbombo che ci si sono all’asilo. Il pavimento è duro, di piastrelle fredde. Un pavimento da scarpe e non da pantofole. All’ingresso la maestra si ferma. Si mette il dito davanti al naso e fa il suono del silenzio: «Sssttttt!» Come se noi a parlare svegliassimo qualcuno. Eppure il pa’ dice sempre a mio fratello che a scuola non si va per dormire.
«Ecco i pulcini!» esclama una bidella, sorridendoci.
Io guardo in terra, di qua e di là, per un attimo penso ci siano davvero. Magari ce ne regalano uno per uno. All’asilo ci avevano regalato un baco da seta arancione che io ho messo in un barattolino del Vicks vuoto aspettando che diventasse farfalla. Non c’è neanche il salone dove correre in ordine sparso, ma un lungo corridoio per cam- minare in fila. Niente dondoli, solo armadi a vetri con dentro libri, tutti uguali, rivestiti con carta da pacco. L’unica cosa con un po’ di colore è un poster in rilievo del corpo umano. Lo guardo un attimo e sento subito che non mi piace, mi sembra una cosa da ospedale. Arrivati in prossimità della classe, la maestra ci dice che tra poco faremo il nostro primo lavoro, un bel disegno, prima però dobbiamo scegliere il simbolo sull’attaccapanni che ci piace di piuù. Dovremo ricordarcelo bene perché ci indicherà il posto per il nostro cappotto. I bambini allora rompono la fila e si sparpagliano di qua e di là lungo la parete. Mi muovo anch’io, vagando un po’ in su e in giuù, più che altro perché lo fanno gli altri. Non ho idea di cosa sia un simbolo.
Qualche bambino appende il golf ai gancini. Bene, allora il gancio è il simbolo, peccato che io non abbia niente da appendere, ho solo il mio bel grembiule bianco, nuovissimo, e, ovviamente, la cartella. Mi monta la rabbia.
“Perché la mamma non mi ha dato un golf?” penso. “Non sapeva che bisognava appenderlo?”
Per un attimo penso che forse, svelta svelta, potrei togliere la cartella, poi il grembiule, per sfilarmi il maglione che ho sotto e appenderlo, appenderlo al gancio-simbolo vicino al disegno del palloncino. È rotondo, rosso e mi piace da matti perché sembra un po’ un cuore, ma un bambino l’ha già occupato col suo cappello a visiera. Allora, a colpo d’occhio, il gelato a fianco. Una bambina che mi sembra molto piccola si mette a frignare perché il gelato lo vuole lei. Passo oltre, e oltre ancora perché i vari posti cominciano a essere tutti occupati. Mi piacerebbe l’uva, che però è già stata presa. Cosiì anche la barca e il sole. Idem per rana e fragola. Il mio respiro accelera. Decido di non fermarmi più a scegliere una cosa che mi piace, ma una cosa libera. C’è ancora qualche bambino sparso alla ricerca del suo gancio-simbolo mentre la maggioranza eè a posto. Arrivo in fondo alla fila e poi devo correre di nuovo all’inizio. Un ritardatario come me si inchioda sotto allo scoiattolo. Mi rimane il posto con la banana.
Caspita. La maestra non diceva così per dire. Qui non ci sono le signorine che scelgono per te. Sei tu che devi farlo e tutti sono stati più svelti di me. A scegliere e a capire che bisognava scegliere. Mi vien subito voglia di tornare a casa dalla Simo e dagli orsi, al galoppo del mio cavallino dal pelo maculato. Da un’aula si sente arrivare un applauso e poi delle risate. Da un’altra, invece, un gran colpo, come di una manata sulla cattedra. Poi la maestra Delfina apre una porta, dice di sceglierci un posto e di andare a sederci.
Rimango a fissare il disegno del palloncino che avrei voluto per me. Mi ci appendo con gli occhi mentre i compagni entrano in classe.