 È da poco uscito Pierino Porcospino. Prima icona della letteratura per l'infanzia, un bel saggio di Martino Negri, ricercatore all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove insegna didattica della letteratura e letteratura per l'infanzia, già autore di Viperetta. Storia di un libro sull'opera di Antonio Rubino che abbiamo recensito qui, e curatore dei volumi Figure dell'infanzia di Walter Benjamin, e Tra i miei mondi, autbobiografia di Leo Lionni. La storia di questo personaggio e del libro di cui è protagonista è particolarmente interessante e signifcativa, nello studio della letteratura illustrata per ragazzi, per questo abbiamo chiesto all'autore di permetterci di pubblicare un paragrafo del libro. Lo ringraziamo per aver accolto la proposta.
È da poco uscito Pierino Porcospino. Prima icona della letteratura per l'infanzia, un bel saggio di Martino Negri, ricercatore all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove insegna didattica della letteratura e letteratura per l'infanzia, già autore di Viperetta. Storia di un libro sull'opera di Antonio Rubino che abbiamo recensito qui, e curatore dei volumi Figure dell'infanzia di Walter Benjamin, e Tra i miei mondi, autbobiografia di Leo Lionni. La storia di questo personaggio e del libro di cui è protagonista è particolarmente interessante e signifcativa, nello studio della letteratura illustrata per ragazzi, per questo abbiamo chiesto all'autore di permetterci di pubblicare un paragrafo del libro. Lo ringraziamo per aver accolto la proposta.
[di Martino Negri]
Colto nella prospettiva della storia dell’educazione, la figura di Pierino si presta meravigliosamente a una riflessione sulla figura ambivalente dell’enfant sauvage, il bambino selvaggio: figura centrale nella riflessione pedagogica a cavallo tra Sette e Ottocento, nel passaggio dalla cultura pedagogica dell’Illuminismo a quella romantica , e figura cruciale, ora, per mettere a fuoco le contraddizioni insite nell’idea di educazione propria della cultura borghese, all’epoca dello Struwwelpeter in pieno sviluppo. Non si deve dimenticare che la moderna letteratura per l’infanzia è nata in un momento storico preciso, contestualmente al diffondersi di un modo nuovo di immaginare il bambino e la sua alterità – cognitiva ed emotiva – rispetto alla condizione dell’adulto, intesa nell’ottica di una maggiore prossimità con la natura: condizione di privilegio, per alcuni, da preservare per il dono di innocenza e purezza di cui sarebbe portatrice («Tutto è bene uscendo dalle mani dell’Autore delle cose, tutto degenera fra le mani dell’uomo» scriveva Rousseau nel citatissimo incipit dell’Emilio ); per altri, bruta selvatichezza da addomesticare – anche attraverso gli exempla offerti da storie concepite ad hoc – alle forme della civiltà, ovvero della sottomissione alle regole della convivenza sociale dell’immaginario borghese, da cui la forza primigenia e informe del desiderio selvaggio era bandita nel nome di più codificate e artificiose forme di passione . È il tempo dello scontro tra il mito rousseauiano del «buon selvaggio», accolto e celebrato dai sacerdoti del Romanticismo , e il suo rovescio, l’infelice Pierino Porcospino, stigmatizzato dai benpensanti per la sua inadeguatezza sociale e votato al supplizio delle forbici e del pettine.

Va rilevato, in questo senso, come la traduzione di Gaetano Negri, spesso geniale nonostante l’infedeltà alla lettera del testo originale tedesco, abbia qui uno dei suoi momenti più felici e, da un punto di vista esegetico, anche fecondi; porla a confronto con una traduzione letterale lo mostra chiaramente.
Il testo letterale recita così:
Guarda un po’, qui c’è lui,
vergogna! Il Piero-coi-capelli-arruffati!
Su tutte e due le mani
non si lascia tagliare
le unghie da quasi un anno;
e non si lascia pettinare i capelli.
Vergogna! Gridano tutti:
è quel sudicione del Piero-coi-capelli-arruffati!
La traduzione storica del 1891 dice invece:
Oh, che schifo quel bambino!
È Pierino il Porcospino:
egli ha l’unghie smisurate,
che non furon mai tagliate.
I capelli, sulla testa,
gli han formato una foresta,
densa, sporca, puzzolente.
Dice a lui tutta la gente:
Oh che schifo quel bambino
È Pierino il Porcospino.
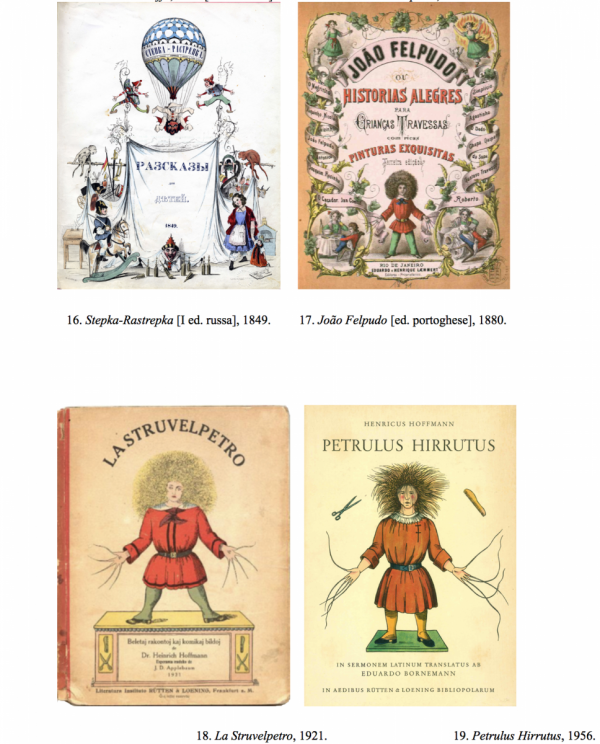
La traduzione di Negri è in ottonari impeccabili, un tipo di verso dal ritmo regolare e orecchiabile che sarebbe diventato di lì a poco molto familiare ai bambini italiani in quanto misura metrica caratteristica dei versi che avrebbero accompagnato, a partire dal Natale del 1908, le tavole a quadretti delle prime storie a fumetti pubblicate sul neonato «Corriere dei piccoli» . Non è tuttavia la perfezione metrica dei versi a interessarci in questo contesto, quanto piuttosto gli elementi che Negri introduce nel testo, sottolineando la mancanza di misura delle unghie di Pierino – unghie che mai furono tagliate! – e trasformando la testa arruffata del personaggio, che rifiuta di sottoporsi alla tortura del pettine, la prassi borghese della toeletta quotidiana, in una vera e propria «foresta», per di più «densa, sporca, puzzolente». Il traduttore introduce insomma un significativo rimando alla dimensione boschiva, matrice simbolica della selvatichezza intrinseca al personaggio, che assume qui la forma del rifiuto delle norme di comportamento imposte dagli adulti, nelle quali risuona metaforicamente l’eco lontana della legge e della misura che sono a fondamento della società e della civiltà stessa.

Una civiltà che si può affermare solo in opposizione alla «foresta» e nel segno della rinuncia – ora nostalgica ora dolorosa – a un rapporto mitico e armonico con la natura, individuato come proprio dell’infanzia (che diviene in questo senso un’età dell’oro che l’essere umano è destinato ad attraversare e perdere) e punto di scaturigine, per tutto l’Ottocento, di potenti metafore d’infanzia, dal fremde Kind [Il bambino estraneo] di E.T.A. Hoffmann , il cui titolo è stato non a caso ripreso dal Richter per il suo poderoso lavoro di riflessione sulla nascita dell’immagine dell’infanzia nel mondo borghese, al racconto che apre il primo Libro della giungla di Kipling, col quale il secolo si chiude e dove il trauma del distacco da un’epoca della vita e da un contesto mitico si compie nel segno di un destino dai tratti sinistramente mortiferi al quale tuttavia non è possibile sfuggire:
E allora Mowgli cominciò a sentire qualcosa che faceva male dentro, male come non aveva mai sentito in vita sua, e trattenne il respiro e singhiozzò, e le lacrime gli solcarono il viso.
– Che cos’è? Che cos’è? – disse. – Io non voglio lasciare la Giungla e non so che cos’è questa cosa. Non starò morendo, Bagheera?
– No, Fratellino. Sono soltanto lacrime, com’è degli uomini, – disse Bagheera. – Ora so che sei un uomo, e non più un cucciolo d’uomo. Invero d’ora in poi la Giungla ti è preclusa. Lasciale cadere, Mowgli. Sono soltanto lacrime –. Così Mowgli sedette e pianse come se dovesse spezzarglisi il cuore; e non aveva mai pianto prima in vita sua.

Potremmo allora forse spingerci a dire, rimanendo all’interno di un discorso di natura metaforica, che Negri ha inconsapevolmente esplicitato, attraverso l’immagine della chioma-foresta, la lotta sotterranea tra natura e cultura che, anche da un punto di vista simbolico, trova nelle teorie dell’educazione, storicamente, uno dei suoi privilegiati territori di scontro, mantenendo peraltro viva la sua forza seduttiva sull’immaginario contemporaneo, come rileva Matteo Baraldi:
I fanciulli selvaggi incarnano infatti, nel mondo occidentale, la speranza di un impossibile e totale ritorno alla natura, a una selvatichezza libera e incontrollata, ed anche per questo, mano a mano che le nostre città si addentrano, o sprofondano, nel mondo postmoderno e postindustriale, questo è un mito che continua a parlare alle nostre coscienze. Ed è un mito talmente forte e vivo da presentarsi ancor oggi sotto nuove forme…

È proprio il tema del rapporto conflittuale con l’idea stessa di norma a rendere la figura del bambino selvaggio – o meglio, quella del bambino in quanto «selvaggio» – una figura mitica alla quale gli adulti hanno guardato affascinati in diverse epoche storiche, quella presente non esclusa, come evidenzia anche Raffaele Mantegazza (in Nostalgia di Victor. L’infanzia tra assedio educativo e solitudine tecnologica, in V. Brogi, L. Mori, Il bambino selvaggio: atti degli incontri internazionali di Castiglioncello, ETS, Pisa 2010), per il quale bambini e bambine diventano in questo senso «il paradigma di una illusoria liberazione dalla Norma»:
disobbedire è un modo di essere dell’infanzia che non può che affascinare l’adulto, costretto (spesso da se stesso) all’obbedienza. Chi ha interiorizzato, attraverso un lungo e penoso tirocinio, le esigenze della Norma sociale, vede nel bambino e nella bambina l’incarnazione e la proiezione di quegli impulsi che ha imparato a reprimere o alla meglio a sublimare; nasce qui il mito del fanciullo come sovvertitore dell’ordine borghese repressivo; si costituisce in questa piega dell’immaginario occidentale l’idea di una infanzia disobbediente e dunque portatrice di libertà; la libertà di mettersi le mani nel naso, di ignorare le convenzioni, di sfidare l’adulto sul piano del comportamento e della regola.
