[di Giovanna Zoboli]
Ho conosciuto Letizia Soriano su Facebook. Il mio lavoro mi porta a seguire sui social, e poi a incontrare, diversi insegnanti con i quali non di rado si instaurano buoni rapporti, fondati su reciproca stima e affinità di vedute, a volte amicizie vere e proprie. Di Letizia mi colpì l’intelligenza e l’impegno, e, sì, anche il divertimento che profonde nel fare il mestiere di insegnante di scuola primaria. Tutte le volte che scriveva, raccontando della sua scuola e della scuola in generale, notavo un occhio acuto nell’osservare dinamiche, situazioni, bambini, genitori, colleghe, colleghi, e anche la capacità di riflettere su grandi questioni teoriche.
Un giorno, era la primavera del 2022, le chiesi se fosse interessata a scrivere un pezzo per il blog Topipittori sul lavoro di Margherita Zoebeli, figura che Letizia, riminese di adozione, conosce bene per aver frequentato il CEIS Centro educativo italo svizzero, fondato da Zoebeli. Dopo questo articolo ne sono venuti altri ventiquattro, sugli argomenti più diversi. Cosicché Letizia è diventata una delle collaboratrici più assidue e apprezzate del nostro blog. Conoscendo i pregi della sua scrittura, chiara, brillante, acuta, mai prolissa, si capisce bene per quale ragione lo sia. Tuttavia, non avevo idea che la sua scrittura, che pure apprezzavo e apprezzo, avesse toccato il periglioso e scivoloso ambito della poesia. Quindi, quando mi parlò di una sua raccolta in via di pubblicazione e mi chiese di darle un parere sui possibili titoli che aveva scelto, per me fu una vera sorpresa.
A raccolta uscita (Io per esempio sono una che ringrazia, prefazione Silvia Vecchini, Interno Poesia 2025), ci ritrovai la medesima qualità di pensiero e di forma dei suoi articoli, ovviamente trasposta in un altro linguaggio. Per questi motivi ho pensato di dedicare al suo libro un’intervista. Tuttavia, la ragione principale è un’altra. Per dirla, uso alcune parole di Silvia Vecchini tratte dalla prefazione:
«Nel libro di Letizia Soriano (insegnante, appassionata di pedagogia, ricercatrice di storie che raccontano la scuola, interessata da sempre all’intercultura, formatrice, sia in Italia sia all’estero, all’interno di progetti di Cooperazione Internazionale per la promozione dell’inclusione sociale) si sente l’odore dell’infanzia, la propria e quello delle altre infanzie che l’autrice incontra. Tove Ditlevsen, in un altro passaggio del suo meraviglioso libro, scriveva anche “l’infanzia è lunga e stretta come una bara, e non si può uscirne da soli” ecco che se torno su questo passaggio leggo meglio le incursioni dei bambini nei versi di Letizia.»
La proposta di questo libro sul nostro blog dipende, quindi, soprattutto, dal posto di primo piano che l’infanzia vi occupa: l’infanzia di chi ha scritto e la cui voce parla e riflette in queste pagine, ma anche l’infanzia dei molti bambini e bambine incontrati, conosciuti, frequentati nel passato e nel presente, da insegnante, madre, educatrice, semplice osservatrice. Presenze che sembrano risolutive e chiare nel disordine dei giorni e dei luoghi, nei momenti di caos interiore, nello sperdimento.

1
La prima domanda che rivolgo a Letizia Soriano è proprio questa: in che modo, pur senza (la diffusissima abitudine di) attribuirle proprietà salvifiche, l’infanzia sia diventata per te una sorta di strumento di orientamento.
Dell’infanzia mi orienta la determinazione di stare dentro un pensiero tanto concreto quanto astratto (o fantastico) quindi fatato o stregato, in base al bisogno. Nell’infanzia, a differenza della vita adulta, è ancora tutto trasformabile e ancora tutto salvabile. I bambini hanno la capacità, a volte sfinente, di raggiungere i loro obiettivi, costi quel che costi. Questo vale sia per le situazioni più idilliache sia per quelle più disperate. In questo senso possedere una capacità trasformativa del mondo (sia quello visibile sia quello invisibile) è fondamentale per riuscire a raggiungere anche gli obiettivi più complicati, e da lì orientarsi. Si parla tanto di problem solving, di quanto sia necessario sviluppare questa abilità. I bambini ce l’hanno costantemente a disposizione, hanno un’idea per ogni cosa e troppo spesso non vengono ascoltati. Possono essere idee folli, esagerate, difficilmente praticabili, però rivelano parti importanti della loro vita interiore, dei loro desideri, della loro volontà di modificare le situazioni. Io sono stata una bambina non ascoltata, questo ha significato, a un certo punto, cominciare a tacere e dubitare di tutto quello che mi passava dentro. Però non ha cancellato il bisogno di trovare l’energia per dare una spiegazione a certe situazioni e soprattutto a cercare le parole per nominare quello che vivevo
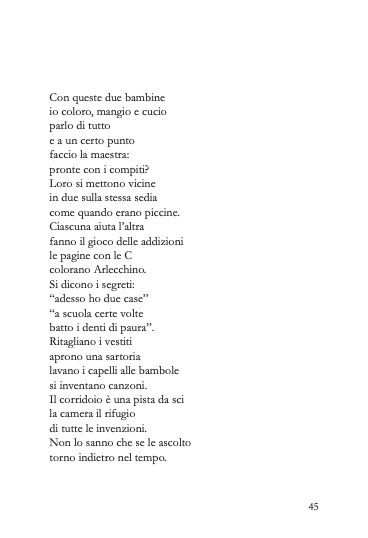
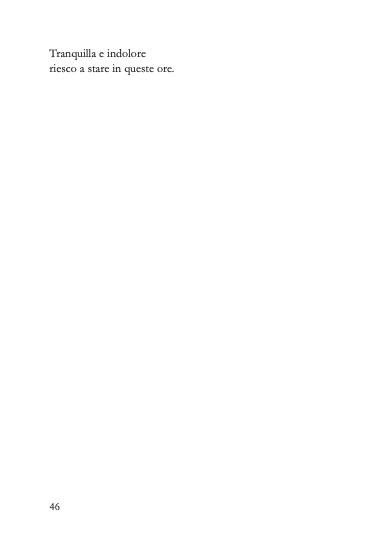
L’altro incontro fondamentale che si percepisce in queste liriche, diventato principio ordinatore, innesco di libertà, di senso e di forma, è la parola, in particolare, quella poetica, come se fra poesia e infanzia ci fosse prossimità, anche in questo caso ben lontani dallo stereotipo che vuole i bambini poeti naturali e la poesia, la panacea di tutti i mali.
Sì, la parola mi ha sempre dato la possibilità di fare ordine già a partire dall’infanzia che, come accennavo sopra, è stata un’infanzia complicata dentro una famiglia che non aveva le risorse per accorgersi di me. La parola è arrivata in due forme, la prima grazie ai libri della biblioteca della mia scuola elementare dove passavo i pomeriggi nell’attesa che mia madre finisse di lavorare. È qui che si è aperta la porta per entrare nella vita di alcuni personaggi. Uno tra tutti: Humphrey, il protagonista de L’Incompreso e poi Mary, Colin e Dickon i bambini de Il giardino segreto. Erano i miei compagni, li sentivo davvero molto vicini.
Poi è arrivata la parola scritta, dentro i miei diari di bambina che non poteva avere la sua cameretta. Ecco, la scrittura è stata la mia cameretta. Lì nessuno, davvero nessuno, poteva entrare, se io non volevo; potevo finalmente decidere se tenere la luce accesa o spenta, se riordinare o lasciare tutto per aria. Nessuno poteva dirmi: questo va bene e quest’altro no, decidevo io le parole da tenere e quelle da buttare. Era, ed è ancora, il luogo in cui mi sento veramente libera.
Fin dalla prima lirica della tua raccolta, assenza e mancanza sembrano costituire due elementi essenziali nel racconto della tua storia ed esperienza. Spazi incerti o pericolosi, parole non dette, tempi vuoti, tracce cancellate, ricordi perduti, persone che non ci sono più, oggetti e luoghi carichi di solitudine. Da tutto questo sembra nascere, però, una segretezza, uno spazio interno in cui pensare le cose. Quindi, una risorsa. E questa cosa mi riporta di nuovo all’infanzia che ha questa abilità a fare del vuoto, pieno. Leggendo il titolo Poesie nascoste, quello della prima sezione del libro (diviso in tre parti, corrispondenti a tre fasi cronologiche, dalla più recente alla più remota), mi sono data questa risposta. Ma vorrei sentire la tua spiegazione.
Credo che uno spazio, per essere realmente segreto, abbia bisogno di essere custodito con grande attenzione. E per arrivare a quello spazio interno in cui pensare le cose (e scriverle, e poi scriverle come meritano di essere dette) ho avuto bisogno, sin dall’infanzia, di osservare le situazioni accuratamente. Nel mio caso non bastava sentire una mancanza, un pericolo, un ricordo, perché mi sarei lasciata inghiottire. Era necessario per me analizzare quella mancanza, quel pericolo, quel ricordo e contestualizzarli, dare loro un po’ di respiro. Forse la risorsa è stata di capire questo molto presto. In questo passaggio la scrittura mi ha sempre aiutato a fare ordine, come dicevamo sopra, ma soprattutto è stata necessaria a far sì che, dentro quello spazio, che era fatto di solitudine, non mi sentissi mai realmente sola, e non mi perdessi. E infatti così è stato. Non ero sola perché c’era lei, la scrittura, con me. È stata, ed è, la mia più cara amica, la mia bussola.
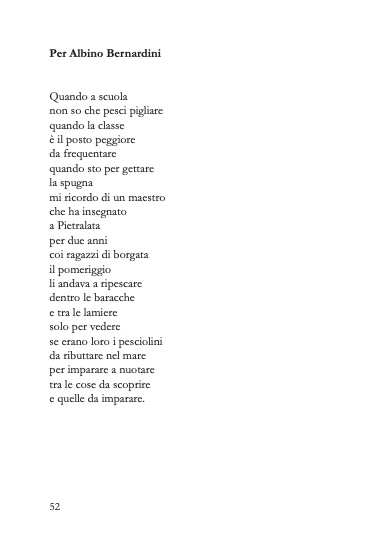
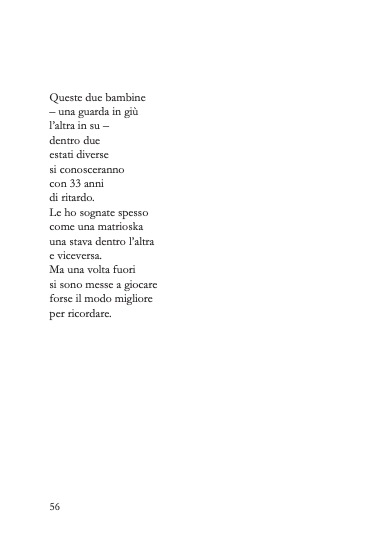
Ogni infanzia è sempre anche storia familiare. Nei tuoi testi questa si riverbera in modo doloroso, il lettore ne percepisce la complessità, il disagio, ma al tempo stesso rinviene in essa la strada maestra per quella che è diventata una comprensione lucida della tua infanzia e di quella altrui, di chi l’ha lasciata dietro di sé, ma anche di chi la sta vivendo ancora.
Certe volte, quando si vivono storie familiari complesse, si ha la presunzione di sentirsi in qualche modo speciali o diversi. Questo può creare un distacco molto forte dalla realtà, e il distacco è rischioso soprattutto se si fa un lavoro come il mio. È indispensabile che le parti ferite siano guarite o in via di cicatrizzazione, quando si ha a che fare con l’infanzia (ma non solo), perché altrimenti quel vissuto diventa subito un ricatto, un peso, un attacco alla felicità dell’altro. O peggio: quando l’altro manifesta un disagio si fa in automatico il paragone con quello che si è vissuto, e il dolore degli altri non è mai all’altezza del proprio. Questo, secondo me, è un pensiero profondamente ingiusto. Quindi, per tornare alla domanda, avendo lavorato per tanti anni a testa bassa sulle dinamiche familiari, adesso forse riesco a comprenderle, a parlarne e a scriverne con la giusta distanza. Al contempo, grazie a quel tipo di vissuto, ho la possibilità di immedesimarmi in modo profondo con il vissuto dei bambini che incontro, perché, anche se sono passati tanti anni, avverto ancora, con la stessa chiarezza, certe sensazioni dell’infanzia. Allo stesso modo riesco ad adottare alcune strategie sperimentate da bambina per sopravvivere agli adulti che ho intorno. Come posso non pensare che sia lo stesso anche per i bambini di adesso?
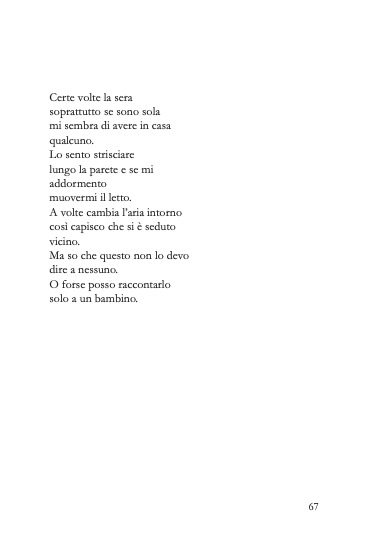
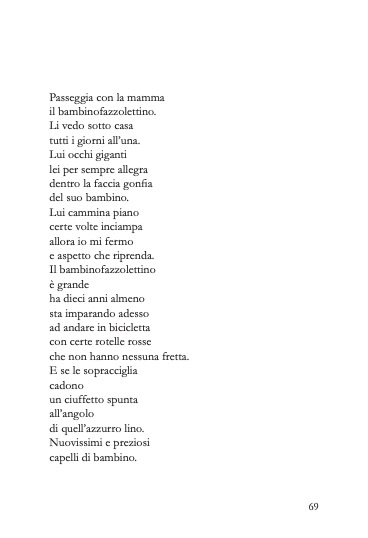
In alcune di queste poesie appare la scuola. Hai un modo molto interessante di rappresentarla, da una parte restituendone la precarietà, la trasandatezza intesa come depositarsi nel tempo di trascuratezze, indifferenza e disattenzione, ma dall’altra, anche qui, di spazio straordinariamente vivo, abitato dalla vita, uno dei pochi dove veramente è possibile percepire ancora pensiero, affetto e gioia.
Integrare gli aspetti di cui parli (anche se appaiono molto distanti tra loro) non è complicato, se si pensa alla scuola un po’ come a una casa. Dentro si piange, si ride, si festeggia, ci si distrae, si canta, ci si arrabbia, si parla e si sta in silenzio. So che alcune colleghe potrebbero trasalire leggendo queste parole, ma per me scuola e casa si equivalgono. La scuola è stato il primo posto dove sono stata vista, ascoltata e presa in considerazione realmente, e questo non posso dimenticarlo. Le mie maestre non utilizzavano dei metodi particolari, ma erano capaci di vederci, e questo nella vita di un bambino può significare moltissimo. E poi sono state loro a insegnarmi a leggere e a scrivere, che è come andare in bicicletta: una volta imparato, non si dimentica più. Da lì non ho più smesso grazie alla biblioteca che mi ospitava e ai diari che scrivevo, l’unica “stanza tutta per me”. Crescendo ho mantenuto intatte le mie due vite parallele: quella scritta sulla carta e l’altra, in mezzo agli altri.
Senza la scuola tutto questo non sarebbe potuto accadere, perciò quando sono al lavoro mi prendo la libertà di affrontare il quotidiano per quello che è. Quotidiano che è fatto di tante cose, spesso in totale contrapposizione tra loro, quindi uno spazio che ha continuamente bisogno di essere ripensato e reiventato. Dentro questa complessità io continuo a sentirmi a mio agio e nel posto giusto.
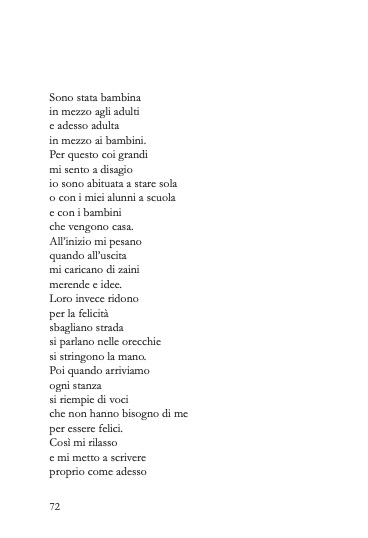
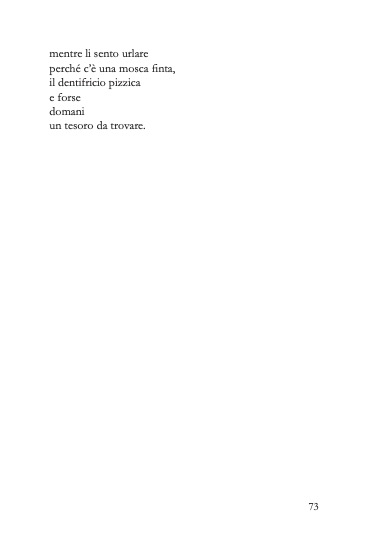
In questi tuoi versi, infine, trovo un’attitudine simile a quella della fiaba, quella di volgere il piombo in oro: ovvero dalla narrazione di una condizione di partenza cupa, minacciosa, disagevole, a quella di una fine dove si trova una possibile giustizia, un riscatto, la scoperta di un luogo abitabile e (abbastanza) sicuro, si recupera senso e respiro. E anche questa è una cosa mi fa pensare molto all’infanzia e al suo modo di guardare alle cose.
Ricordo la mia infanzia come un luogo in cui la percezione del mondo era ancora intatta e potenzialmente in grado di trasformarsi. Per questo la comprensione più razionale di tutti quegli aspetti cupi o disagevoli è arrivata dopo. Durante, c’era l’urgenza di trovare scappatoie e strategie, utili a vivere nel modo migliore di cui ero capace, di prendere il meglio e tenermelo stretto. Sono stata una bambina che ha immaginato e fantasticato a lungo situazioni parallele (più felici) di quelle che vivevo. Ci mettevo talmente tanto impegno che a volte scambiavo il mio immaginario con la realtà. Questo mi ha salvato parecchie volte. Ed è un’abitudine che mi è rimasta, ma non come propensione leziosa alla fantasticheria, come distacco dalla realtà, piuttosto come inclinazione a voler scoprire un’altra faccia, un’altra possibilità (preferibilmente ironica) delle cose che mi gravitano attorno. Da questo punto di vista la mia infanzia non ha un’età anagrafica precisa perché continua a costruire l’adulta che sono, continua a nutrire tutte le cose belle che faccio e che mi riempiono di gratitudine e soddisfazione. Come questa intervista. Sto pensando che forse in tutti questi anni ho seminato qui e lì delle molliche di pane che a un certo punto mi hanno fatto trovare la strada.
